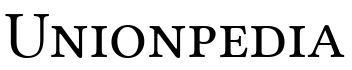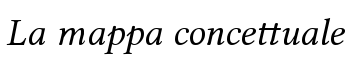Indice
45 relazioni: Acenaftene, Acetil-coenzima A, Acidi dioici, Acido 2-chetoglutarico, Acido glutammico, Acido γ-amminobutirrico, Acido malonico, Acido piruvico, Agmatina, Ammine, Amminoacido, Anidride carbonica, Arginina, Cadaverina, Chimica, Chimica organica, Ciclo di Krebs, Cicloesanone, Condensazione di Knoevenagel, Decarbossilasi, Difenilmetano, Dopamina, Etanolammina, Fenilalanina, Glicerolo, Istamina, Istidina, L-DOPA, Lisina, Metabolismo, Noradrenalina, Olio minerale, Ornitina, Putresceina, Rame, Reazione chimica, Reazione di Hunsdiecker, Reazione di Kolbe-Schmitt, Serina (chimica), Serotonina, Substrato (biochimica), Succinil-coenzima A, Tirosina, Triptofano, 2-feniletilammina.
- Reazioni di sostituzione
Acenaftene
L'acenaftene è un idrocarburo aromatico di origine naturale, derivante come struttura dal naftalene.
Vedere Decarbossilazione e Acenaftene
Acetil-coenzima A
L'acetil-coenzima A (CH3COSCoA) spesso abbreviato in acetil-CoA, è una molecola fondamentale nel metabolismo di tutti gli organismi viventi.
Vedere Decarbossilazione e Acetil-coenzima A
Acidi dioici
Gli acidi dioici sono una classe di composti organici alifatici (e raramente aromatici o misti); gli alifatici sono costituiti da una catena idrocarburica con le due estremità carbossiliche (-COOH).
Vedere Decarbossilazione e Acidi dioici
Acido 2-chetoglutarico
L'acido 2-chetoglutarico (anche acido 2-ossoglutarico o acido α-chetoglutarico) è un acido carbossilico. A temperatura ambiente si presenta come un solido da bianco a giallo chiaro quasi inodore.
Vedere Decarbossilazione e Acido 2-chetoglutarico
Acido glutammico
L'acido glutammico è un amminoacido utilizzato dagli esseri viventi per la sintesi delle proteine. Viene indicato comunemente con le sigle E o Glu ed è codificato sull’RNA messaggero dai codoni GAA e GAG.
Vedere Decarbossilazione e Acido glutammico
Acido γ-amminobutirrico
Lacido γ-amminobutirrico (GABA), noto anche come acido 4-amminobutanoico, è un γ-amminoacido composto da quattro atomi di carbonio, isomero dell'acido amminobutirrico ed è il principale neurotrasmettitore inibitorio nel sistema nervoso centrale nell'uomo.
Vedere Decarbossilazione e Acido γ-amminobutirrico
Acido malonico
L'acido malonico (nome sistematico: acido 1,3-propandioico) è un acido bicarbossilico, ovvero la sua molecola reca due gruppi carbossilici (-COOH); nella sua molecola questi sono uniti da un ponte metilene; la sua formula molecolare è quindi HOOC−CH2−COOH.
Vedere Decarbossilazione e Acido malonico
Acido piruvico
L'acido piruvico (o acido α-chetopropionico, nome sistematico: acido 2-ossopropanoico) è un alfa-chetoacido, ossia un acido carbossilico che reca un gruppo chetonico unito direttamente al carbossile, avente quindi formula CH3-CO-COOH.
Vedere Decarbossilazione e Acido piruvico
Agmatina
L'agmatina è il prodotto della decarbossilazione dell'amminoacido arginina ed è un intermedio nella biosintesi delle poliammine. È sintetizzata nel cervello e conservata nelle vescicole sinaptiche.
Vedere Decarbossilazione e Agmatina
Ammine
Le ammine sono composti organici contenenti azoto; si possono considerare composti derivati dall'ammoniaca per sostituzione formale di uno, due o tre atomi d'idrogeno con altrettanti gruppi alchilici o arilici.
Vedere Decarbossilazione e Ammine
Amminoacido
Gli amminoacidi sono una vasta categoria di molecole organiche che hanno sia il gruppo funzionale amminico (-NH2), sia quello carbossilico (-COOH). La parola amminoacido deriva dall'unione dei nomi di questi due gruppi funzionali.
Vedere Decarbossilazione e Amminoacido
Anidride carbonica
Il diossido di carbonio, noto anche come biossido di carbonio o anidride carbonica, (formula: CO2) è un ossido del carbonio formato da un atomo di carbonio legato da due doppi legami a due atomi di ossigeno.
Vedere Decarbossilazione e Anidride carbonica
Arginina
L'arginina è un amminoacido polare (con catena laterale idrofila) basico. La basicità dell'amminoacido è dovuta al gruppo guanidinico che caratterizza la sua catena laterale e che è fortemente basico.
Vedere Decarbossilazione e Arginina
Cadaverina
La cadaverina, una diammina fetida, è un prodotto di degradazione delle proteine. In particolare, è il prodotto di decarbossilazione dell'aminoacido lisina, reazione catalizzata dall'enzima lisina decarbossilasi.
Vedere Decarbossilazione e Cadaverina
Chimica
La chimica (da kemà, il libro dei segreti dell'arte egizia, da cui l'arabo "al-kimiaa" "الكيمياء") è la scienza naturale che studia la composizione, la struttura e le proprietà della materia, sia essa in forma di elementi, specie, composti, miscele o altre sostanze, e i cambiamenti che questi subiscono durante le reazioni e il loro rapporto con l'energia chimica.
Vedere Decarbossilazione e Chimica
Chimica organica
La chimica organica si occupa delle caratteristiche chimiche e fisiche delle molecole organiche. Si definiscono convenzionalmente composti organici i composti del carbonio con eccezione degli ossidi, monossido e diossido, e dei sali di quest'ultimo: anione idrogenocarbonato ed anione carbonato rispettivamente, derivati solo formalmente dall'acido carbonico (in realtà inesistente in soluzione acquosa), oltre ad altre piccole eccezioni.
Vedere Decarbossilazione e Chimica organica
Ciclo di Krebs
Il ciclo di Krebs (anche detto ciclo degli acidi tricarbossilici, ciclo dell'acido citrico e ciclo dell'ossalacetato) è un ciclo metabolico di importanza fondamentale in tutte le cellule che utilizzano ossigeno nel processo della respirazione cellulare.
Vedere Decarbossilazione e Ciclo di Krebs
Cicloesanone
Il cicloesanone è un chetone ciclico a sei termini avente formula semistrutturale (CH2)5CO. È l'omologo superiore del ciclopentanone. A temperatura ambiente si presenta come un liquido incolore dall'odore che ricorda l'acetone e la menta piperita.
Vedere Decarbossilazione e Cicloesanone
Condensazione di Knoevenagel
La condensazione di Knoevenagel (o reazione di Knoevenagel) è una variante della condensazione aldolica che avviene quando una aldeide o un chetone, in presenza di ammoniaca o una ammina quali catalizzatori, reagiscono con un composto avente α-idrogeni acidi, idrogeni in posizione α rispetto a due gruppi elettronattrattori quali C.
Vedere Decarbossilazione e Condensazione di Knoevenagel
Decarbossilasi
Chiamasi decarbossilasi (carbossile-Liasi) una classe di enzimi che catalizzano una reazione di decarbossilazione la quale porta alla rimozione dalla molecola di un acido organico di uno o più gruppi carbossilici sotto forma di anidride carbonica.
Vedere Decarbossilazione e Decarbossilasi
Difenilmetano
Il difenilmetano, o ditano, è un composto aromatico di formula o. A temperatura ambiente appare come un solido incolore e dall'odore caratteristico, con sistema cristallino ortorombico ed habitus aciculare, praticamente insolubile in acqua ed ammoniaca ma miscibile con etanolo, dietiletere, cloroformio, esano e benzene.
Vedere Decarbossilazione e Difenilmetano
Dopamina
La dopamina, o anche dopammina, è un neurotrasmettitore endogeno della famiglia delle catecolammine. All'interno del cervello questa feniletilammina funziona da neurotrasmettitore, tramite l'attivazione dei recettori dopaminergici specifici e subrecettori.
Vedere Decarbossilazione e Dopamina
Etanolammina
L'etanolammina (o monoetanolammina, talvolta abbreviata in MEA, detta anche colammina) è un composto chimico che ha la funzione di ammina e di alcol.
Vedere Decarbossilazione e Etanolammina
Fenilalanina
La fenilalanina è un amminoacido che partecipa alla costituzione delle più comuni proteine alimentari. La sua molecola è chirale e apolare. L'enantiomero L è uno dei 20 amminoacidi ordinari; il suo gruppo laterale è un gruppo benzile.
Vedere Decarbossilazione e Fenilalanina
Glicerolo
Il glicerolo, o glicerina, è un composto organico nella cui struttura sono presenti tre atomi di carbonio legati a tre gruppi -OH (in altre parole è un "triolo").
Vedere Decarbossilazione e Glicerolo
Istamina
Listamina (o 2-(4-imidazolil)etilammina, formula C5H9N3) è una molecola organica, appartenente alla classe di ammine biogene, uno dei mediatori chimici dell'infiammazione e deriva dalla decarbossilazione dell'istidina ad opera della istidina decarbossilasi; condivide in questa sede numerosi effetti con la serotonina.
Vedere Decarbossilazione e Istamina
Istidina
Listidina (abbreviazioni His e H), chiamata anche L-istidina, è un amminoacido il cui gruppo laterale reca un anello imidazolico. Viene codificata dai codoni CAU e CAC, ed è una molecola polare e chirale.
Vedere Decarbossilazione e Istidina
L-DOPA
L'L-DOPA, o levodopa, è un amminoacido intermedio nella via biosintetica della dopamina. In clinica medica è utilizzata per il trattamento della malattia di Parkinson e di alcuni parkinsonismi per controllare i sintomi bradicinetici evidenti nella malattia ed è il farmaco più efficace per migliorare la qualità della vita nei pazienti con malattia di Parkinson idiopatica.
Vedere Decarbossilazione e L-DOPA
Lisina
La lisina è un amminoacido polare, la sua molecola è chirale. L'enantiomero L è uno dei 20 amminoacidi ordinari, il suo gruppo laterale reca un gruppo amminico che le conferisce un comportamento basico.
Vedere Decarbossilazione e Lisina
Metabolismo
In biochimica il metabolismo (dal greco μεταβολή ossia "cambiamento") è l'insieme delle trasformazioni chimiche che si dedicano al mantenimento vitale all'interno delle cellule degli organismi viventi.
Vedere Decarbossilazione e Metabolismo
Noradrenalina
La noradrenalina (NA) o norepinefrina (NE; DCI) è un neurotrasmettitore; differisce dall'adrenalina in quanto rispetto ad essa manca di un metile legato al gruppo amminico.
Vedere Decarbossilazione e Noradrenalina
Olio minerale
Con il termine oli minerali si indicano dei fluidi che si trovano in natura, creatisi in milioni di anni. Dal punto di vista chimico, gli oli minerali sono delle miscele costituite per la maggior parte da alcani a catena lunga (contenenti circa 15-40 atomi di carbonio).
Vedere Decarbossilazione e Olio minerale
Ornitina
L'ornitina è un aminoacido non proteogenico. È uno dei prodotti dell'enzima arginasi sulla L-arginina, che crea ornitina e urea. L'ornitina è quindi un prodotto fondamentale del ciclo dell'urea, che permette l'eliminazione dell'azoto in eccesso.
Vedere Decarbossilazione e Ornitina
Putresceina
La putresceina (detta anche putrescina o putrescene) è un composto chimico organico di formula NH2(CH2)4NH2 (1,4-diamminobutano o butano-1,4-diammino) che scaturisce da diversi alimenti in putrefazione e ne reca il caratteristico odore fetido.
Vedere Decarbossilazione e Putresceina
Rame
Il rame è l'elemento chimico di numero atomico 29 e il suo simbolo è Cu. È il primo elemento del gruppo 11 del sistema periodico, facente parte del blocco d, ed è quindi un elemento di transizione.
Vedere Decarbossilazione e Rame
Reazione chimica
Una reazione chimica è una trasformazione della materia che avviene senza variazioni misurabili di massa, in cui una o più specie chimiche (dette "reagenti") modificano la loro struttura e composizione originaria per generare altre specie chimiche (dette "prodotti").
Vedere Decarbossilazione e Reazione chimica
Reazione di Hunsdiecker
La reazione di Hunsdiecker (nota anche come reazione di Borodin, da Alexander Borodin) è una reazione organica tra i sali d'argento degli acidi carbossilici con alogeni per dare i corrispondenti alogenuri alchilici.
Vedere Decarbossilazione e Reazione di Hunsdiecker
Reazione di Kolbe-Schmitt
La reazione di Kolbe-Schmitt, dal chimico tedesco Adolph Wilhelm Hermann Kolbe che l'ha studiata, detta anche più semplicemente reazione di Kolbe, è una reazione organica di carbossilazione in cui il fenato di sodio (sale di sodio del fenolo) è trattato dapprima con anidride carbonica, a una pressione di 100 atmosfere e a una temperatura di 125 °C, e in seguito con acido solforico.
Vedere Decarbossilazione e Reazione di Kolbe-Schmitt
Serina (chimica)
La serina è un amminoacido polare. La sua molecola è chirale. L'enantiomero L è uno dei 20 amminoacidi ordinari, il suo gruppo laterale reca un gruppo idrossile.
Vedere Decarbossilazione e Serina (chimica)
Serotonina
La serotonina o 5-idrossitriptamina (5-HT)Dall'inglese 5-hydroxytryptamine è una triptammina, sintetizzata a partire dall'amminoacido triptofano (5-HTP), che negli animali viene per lo più prodotta dai neuroni serotoninergici nel sistema nervoso centrale e nelle cellule enterocromaffini nell'apparato gastrointestinale, dove partecipa a numerose funzioni biologiche.
Vedere Decarbossilazione e Serotonina
Substrato (biochimica)
Schema dell'ipotesi dell'adattamento indotto tra substrato ed enzima In biochimica si definisce substrato una molecola sulla quale agisce un enzima: i substrati sono dunque le molecole di partenza nelle reazioni chimiche catalizzate dagli enzimi.
Vedere Decarbossilazione e Substrato (biochimica)
Succinil-coenzima A
Il succinil-coenzima A, comunemente abbreviato in succinil-CoA è una combinazione di acido succinico e coenzima A.
Vedere Decarbossilazione e Succinil-coenzima A
Tirosina
La tirosina è un amminoacido polare, la sua molecola è chirale. L'enantiomero L è uno dei 20 amminoacidi ordinari e il suo gruppo laterale è un p-idrossibenzile.
Vedere Decarbossilazione e Tirosina
Triptofano
Il triptofano è un amminoacido poco polare, il suo gruppo laterale è un indolile. È alla base del gruppo di composti delle triptamine. È una molecola chirale.
Vedere Decarbossilazione e Triptofano
2-feniletilammina
La 2-feniletilammina (PEA), o semplicemente feniletillamina, è un alcaloide e un neurotrasmettitore monoamminico biosintetizzato tramite decarbossilazione enzimatica dell'amminoacido fenilalanina.
Vedere Decarbossilazione e 2-feniletilammina
Vedi anche
Reazioni di sostituzione
- Alogenazione di Hell-Volhard-Zelinsky
- Condensazione di Suzuki
- Deaminazione
- Decarbossilazione
- Inversione di Walden
- Nitrazione
- Olefinazione di Peterson
- Orto-metallazione
- Reazione dell'aloformio
- Reazione di Appel
- Reazione di Blanc
- Reazione di Bucherer
- Reazione di Buchwald-Hartwig
- Reazione di Eschweiler-Clarke
- Reazione di Finkelstein
- Reazione di Friedel-Crafts
- Reazione di Gattermann
- Reazione di Gomberg-Bachmann
- Reazione di Heck
- Reazione di Houben-Hoesch
- Reazione di Hunsdiecker
- Reazione di Koenigs-Knorr
- Reazione di Leuckart
- Reazione di Menšutkin
- Reazione di Michaelis-Arbuzov
- Reazione di Mitsunobu
- Reazione di Reimer-Tiemann
- Reazione di Rosenmund-von Braun
- Reazione di Sandmeyer
- Reazione di Swarts
- Reazione di Vilsmeier-Haack
- Reazione di Williamson
- Reazione di Zincke-Suhl
- Reazione di accoppiamento di Cadiot-Chodkiewicz
- Reazione di copulazione
- Reazione di sostituzione
- Reazione di Čičibabin
- Sintesi di Gabriel
- Sintesi di Kolbe
- Sintesi di Strecker
- Sintesi malonica
- Sostituzione elettrofila
- Transesterificazione
- Trasposizione di Claisen